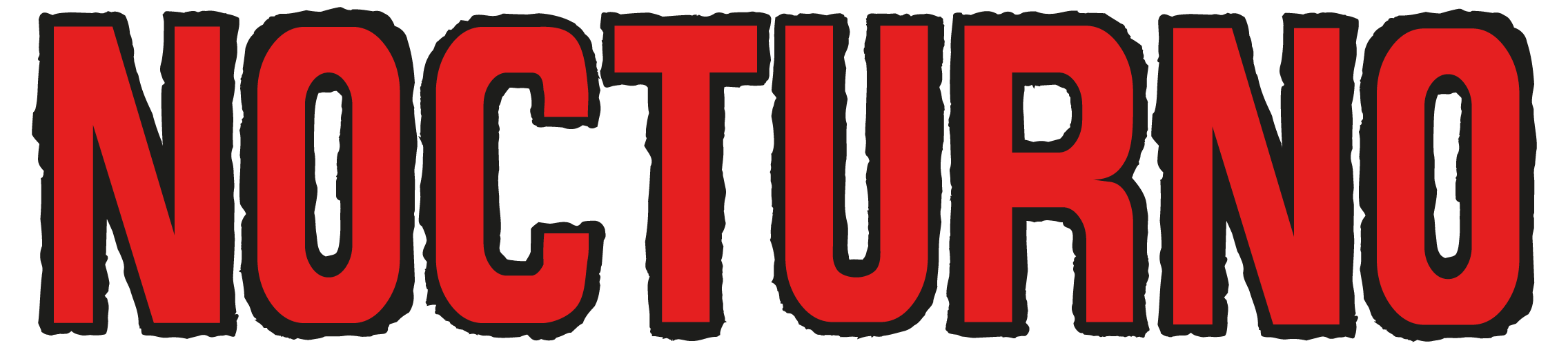La favola orientale, nota anche come “Appuntamento a Samarcanda” o, in altre versioni “Appuntamento a Samarra”, la conosciamo tutti. Nel giardino del re, la Morte appare a un servo o forse è un giovane visir. Per sfuggirle l’uomo monta a cavallo e galoppa a perdifiato tutta la notte. Giunto a Samarcanda l’indomani, incontra però la Morte che lo aspetta. “Non mi hai fatto finire il discorso – dice – in effetti ero un po’ stupita di vederti laggiù visto che oggi dovevo incontrarti qui a Samarcanda”. Senza citarla esplicitamente, un quarto di secolo fa Final Destination ha ripescato la meccanica della fiaba e l’ha estesa a un’intera saga cinematografica mettendo i suoi protagonisti direttamente in competizione contro il proprio destino ma, soprattutto, contro la Triste Mietitrice. Alla fine degli anni ‘90 la vena di maestri come Hooper, Romero, Carpenter sembrava essersi definitivamente affievolita e Wes Craven stesso era saltato sul carro meta horror e quizzarolo di Scream, dove gli slasher fanno l’occhiolino al pubblico e salgono in cattedra interrogando le loro vittime su Venerdì 13 invece di farle semplicemente morire male. Una crisi di iper codificazione a cui New Line Cinema, ora una sussidiaria della Warner con in catalogo robetta come Non aprire quella porta, Polyester, A Nightmare on Elm Street, Alone in The Dark, rispose con un prodotto basico e a suo modo geniale nella sua assoluta non specificità. Dopo tutto, esisterà mai un villain più universale della Morte stessa?
Vuole la leggenda che Jeffrey Reddick, l’autore del soggetto originale, appena quattordicenne si fosse fatto notare da Robert Shaye, founder della New Line, con l’idea di un prequel su Freddy Krueger. Come prevedibile non se ne fece nulla ma, anni dopo, Shaye sposò la sua idea di Final Destination (2000). Originariamente lo script era pensato come un episodio di X Files: un teenager, grazie a un sogno premonitore, evita un disastro aereo e si salva dalla catastrofe con i compagni di viaggio ma la Morte si riprenderà successivamente quello che è suo di diritto. Alla fine Final Destination è a modo suo un horror soprannaturale in bilico con il thriller e il dramma naturalistico. Dopotutto, che sette ragazzi scendano da un aereo poco prima che esploda nel cielo di New York, è già abbastanza strano da attirare i sospetti dall’FBI ma possiamo soltanto immaginare cosa sarebbe successo soltanto un anno più tardi, nel clima paranoico del dopo 11/9. Il senso del film è invece subito rimesso in carreggiata dallo spiegone di un necroforo, un inquietante professionista delle pompe funebri (Tony Todd) che riassume le regole del gioco: “Nella morte non ci sono incidenti,né coincidenze, né contrattempi. E non ci sono scappatoie. Quello che dovete capire è che tutti noi siamo piccoli topi tenuti per la coda da un gatto. Ogni nostro gesto, azione, dalla più banale alla più nobile, il semaforo rosso a cui ci fermiamo o no, Ie persone con cui facciamo sesso o no, gli aerei su cui viaggiamo e dai quali scendiamo, tutto fa parte del sadico disegno della Morte, che conduce alla tomba.” Morale: “Non è il caso di fare incazzare la Vecchia Baldracca”.